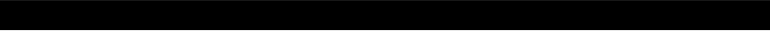

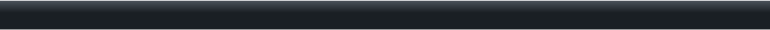


 Fuga da Lukla - Viaggio al Campo Base dell’Everest (parte1)
di Matteo Bergamo
"E sulla bianca schiena dell'animale egli scaricò la somma della rabbia e l'odio provati
Fuga da Lukla - Viaggio al Campo Base dell’Everest (parte1)
di Matteo Bergamo
"E sulla bianca schiena dell'animale egli scaricò la somma della rabbia e l'odio provati dalla propria razza; se il suo petto fosse stato un cannone, egli, gli avrebbe sparato
dalla propria razza; se il suo petto fosse stato un cannone, egli, gli avrebbe sparato contro il suo cuore."
contro il suo cuore." Moby Dick, Herman Melville
Moby Dick, Herman Melville Ci sono alcune montagne che suonano alle mie orecchie come la grande
Ci sono alcune montagne che suonano alle mie orecchie come la grande ossessione del Capitano Achab. Stagione dopo stagione ci reclamano come
ossessione del Capitano Achab. Stagione dopo stagione ci reclamano come sirene maliarde, rocce tramutate in libri di storia e cimiteri viventi
sirene maliarde, rocce tramutate in libri di storia e cimiteri viventi dell'alpinismo. Questa è la loro fascinazione: un costante richiamo alla sfida,
dell'alpinismo. Questa è la loro fascinazione: un costante richiamo alla sfida, ad affrontare i molti mostri che abitano dentro di noi e gli altrettanti pericoli
ad affrontare i molti mostri che abitano dentro di noi e gli altrettanti pericoli fuori. Al trekking del campo base dell'Everest, bisognerebbe amputare la
fuori. Al trekking del campo base dell'Everest, bisognerebbe amputare la parola trekking perché è prima di tutto un viaggio. Un viaggio che inizia con il
parola trekking perché è prima di tutto un viaggio. Un viaggio che inizia con il ronzio dell'elica di un aereo. È già un buon risultato sbarcare a Lukla, in
ronzio dell'elica di un aereo. È già un buon risultato sbarcare a Lukla, in assoluto uno degli aeroporti più insidiosi, incassato tra le montagne come un
assoluto uno degli aeroporti più insidiosi, incassato tra le montagne come un chicco di mais dentro una pannocchia.
chicco di mais dentro una pannocchia.  Katmandu-Lukla sola andata
Katmandu-Lukla sola andata venerdì 11 marzo 2011 ore 5.00 aeroporto di Katmandu
venerdì 11 marzo 2011 ore 5.00 aeroporto di Katmandu L'aeroporto domestico di Kathmandu è un mare agitato: grandi cartoni tenuti
L'aeroporto domestico di Kathmandu è un mare agitato: grandi cartoni tenuti insieme da fili del bucato, ondate di disordine e turisti alla deriva. Fuori è
insieme da fili del bucato, ondate di disordine e turisti alla deriva. Fuori è ancora buio, le luci dei neon complicano ancor di più la mia comprensione di
ancora buio, le luci dei neon complicano ancor di più la mia comprensione di quel mondo brulicante. Tè a colazione, poi saliamo finalmente sull'aereo: è
quel mondo brulicante. Tè a colazione, poi saliamo finalmente sull'aereo: è un insetto pigro, dal muso lungo e una porticina sulla parte posteriore della
un insetto pigro, dal muso lungo e una porticina sulla parte posteriore della carlinga. Ci accoglie una hostess e una quindicina di posti appiccicati tra loro,
carlinga. Ci accoglie una hostess e una quindicina di posti appiccicati tra loro, quasi tutti occupati. La libellula ronza un po', poi si alza in volo. La faccina di
quasi tutti occupati. La libellula ronza un po', poi si alza in volo. La faccina di Chiara è tesa non ha molta fiducia negli aerei che portano il nome Yeti,
Chiara è tesa non ha molta fiducia negli aerei che portano il nome Yeti, Buddha, Tara. Anch'io sono inquieto, sussulto al grido degli altri trekkers che,
Buddha, Tara. Anch'io sono inquieto, sussulto al grido degli altri trekkers che, alla vista delle prime montagne imbiancate, schiacciano le macchine
alla vista delle prime montagne imbiancate, schiacciano le macchine fotografiche contro i finestrini. Dalla mia parte vedo solo terra brulla, che
fotografiche contro i finestrini. Dalla mia parte vedo solo terra brulla, che scemo che sono! Dovevo sedermi dall'altro lato. Dopo cinquanta minuti di
scemo che sono! Dovevo sedermi dall'altro lato. Dopo cinquanta minuti di volo, attraverso i finestrini dei piloti le montagne sembrano farsi sempre più
volo, attraverso i finestrini dei piloti le montagne sembrano farsi sempre più vicine. Improvvisamente tutti tacciono, quindici impulsi cardiaci si fanno ora
vicine. Improvvisamente tutti tacciono, quindici impulsi cardiaci si fanno ora più veloci in quello spazio angusto, l'atterraggio è la discriminante di un
più veloci in quello spazio angusto, l'atterraggio è la discriminante di un viaggio da ricordare oppure no. Quando tocchiamo terra l'aereo singhiozza
viaggio da ricordare oppure no. Quando tocchiamo terra l'aereo singhiozza poi frena bruscamente nel tentativo di arrestare la sua corsa nei
poi frena bruscamente nel tentativo di arrestare la sua corsa nei quattrocentocinquanta metri scarsi di pista in salita. Le chiappe sono strette,
quattrocentocinquanta metri scarsi di pista in salita. Le chiappe sono strette, ogni pensiero revocato. La libellula finisce la sua corsa con un scarto verso
ogni pensiero revocato. La libellula finisce la sua corsa con un scarto verso destra. Ci sarebbe da baciare il suolo, ma simulo una perfetta padronanza dei
destra. Ci sarebbe da baciare il suolo, ma simulo una perfetta padronanza dei miei sentimenti mentre scendo a terra. Veniamo dirottati nel casotto dei
miei sentimenti mentre scendo a terra. Veniamo dirottati nel casotto dei bagagli. Attraverso la rete che delimita l'aeroporto vedo numerosi portatori in
bagagli. Attraverso la rete che delimita l'aeroporto vedo numerosi portatori in attesa. Che aspettano? Noi? Sì, aspettano le vacche d'oro, pronte per essere
attesa. Che aspettano? Noi? Sì, aspettano le vacche d'oro, pronte per essere accompagnate e munte. Nelle loro facce buie è scritta color della terra la
accompagnate e munte. Nelle loro facce buie è scritta color della terra la povertà, l'espediente, la rassegnazione, che insieme condensano in un
povertà, l'espediente, la rassegnazione, che insieme condensano in un inglese mal masticato e rivolto a noi: "Porter, Sir?", "Everest Base Camp, Sir?"
inglese mal masticato e rivolto a noi: "Porter, Sir?", "Everest Base Camp, Sir?"  Om mani padme hum
Om mani padme hum venerdì 11 marzo 2011 Lukla (2.800 m) - Namche (3.440m)
venerdì 11 marzo 2011 Lukla (2.800 m) - Namche (3.440m)  Namche è la nostra prima destinazione, di solito si affronta in due tappe
Namche è la nostra prima destinazione, di solito si affronta in due tappe dormendo a Padking, ma la spedizione italo-parmigiana (io e mia moglie) ha
dormendo a Padking, ma la spedizione italo-parmigiana (io e mia moglie) ha la coperta corta. Quando penso ai nostri viaggi mi chiedo se è sano
la coperta corta. Quando penso ai nostri viaggi mi chiedo se è sano rincorrere in questo modo il tempo. Dobbiamo chiudere il giro in appena
rincorrere in questo modo il tempo. Dobbiamo chiudere il giro in appena sette, otto giorni, ma sappiamo bene che ad alta quota la fretta è amica solo
sette, otto giorni, ma sappiamo bene che ad alta quota la fretta è amica solo dei guai. Il mal di montagna è un preoccupante punto interrogativo nelle
dei guai. Il mal di montagna è un preoccupante punto interrogativo nelle nostre coscienze. Procediamo attraverso un portale decorato che preannuncia
nostre coscienze. Procediamo attraverso un portale decorato che preannuncia l'inizio di una memorabile sgambettata. Seguiamo un sentiero dolce, in lieve
l'inizio di una memorabile sgambettata. Seguiamo un sentiero dolce, in lieve discesa, attraversando decorosi, piccoli villaggi. La vegetazione è rigogliosa,
discesa, attraversando decorosi, piccoli villaggi. La vegetazione è rigogliosa, grandi boschi di rododendro e conifere si alternano a coltivazioni e terre da
grandi boschi di rododendro e conifere si alternano a coltivazioni e terre da pascolo. Viaggiamo attraverso le numerose tracce della religiosità di questo
pascolo. Viaggiamo attraverso le numerose tracce della religiosità di questo popolo: le ruote di preghiera, i cavalli del vento, le pietre mani. Guardo i
popolo: le ruote di preghiera, i cavalli del vento, le pietre mani. Guardo i nostri due portatori, chi sono? È un fattore istintivo per me conoscere chi mi
nostri due portatori, chi sono? È un fattore istintivo per me conoscere chi mi cammina a fianco giorno dopo giorno. È una questione di appartenenza alla
cammina a fianco giorno dopo giorno. È una questione di appartenenza alla stessa specie, quella che fatica e suda insieme, che condivide il sole, la
stessa specie, quella che fatica e suda insieme, che condivide il sole, la pioggia, il vento e la sete. Faccio una fatica tremenda ad accettare che
pioggia, il vento e la sete. Faccio una fatica tremenda ad accettare che trasportino la parte più pesante del mio zaino anche se sono meglio
trasportino la parte più pesante del mio zaino anche se sono meglio acclimatati e sembra che i loro 10/15 kg siano molto più leggeri dei nostri 5.
acclimatati e sembra che i loro 10/15 kg siano molto più leggeri dei nostri 5. Rajan è quello dei due che meglio parla inglese, socievole, robusto, con
Rajan è quello dei due che meglio parla inglese, socievole, robusto, con capelli lunghi e scuri. Ha iniziato come sherpa, poi come cuoco, la famiglia gli
capelli lunghi e scuri. Ha iniziato come sherpa, poi come cuoco, la famiglia gli ha combinato un matrimonio che è finito quando lei, trovandosi ogni santa
ha combinato un matrimonio che è finito quando lei, trovandosi ogni santa notte da sola, si è innamorata di un altro uomo. Ogni volta che ci vede
notte da sola, si è innamorata di un altro uomo. Ogni volta che ci vede sorride, ma il suo sorriso più sincero è quando si tocca la pancia dopo aver
sorride, ma il suo sorriso più sincero è quando si tocca la pancia dopo aver mangiato. L'altro sherpa è Dawa. Smilzo, taciturno, anche lui perennemente
mangiato. L'altro sherpa è Dawa. Smilzo, taciturno, anche lui perennemente affamato. È stato sposato ed ha consumato tutti i suoi soldi per curare
affamato. È stato sposato ed ha consumato tutti i suoi soldi per curare inutilmente la moglie colpita da un male spietato. Ora si è risposato ed ha tre
inutilmente la moglie colpita da un male spietato. Ora si è risposato ed ha tre bocche da sfamare. Quando lo guardo sono io che sorrido: sembra un
bocche da sfamare. Quando lo guardo sono io che sorrido: sembra un bambino imprigionato nell'aspetto di un uomo saggio. Tanti sherpa sono
bambino imprigionato nell'aspetto di un uomo saggio. Tanti sherpa sono come lui: ragazzi già vecchi. Cammina sempre dalla parte giusta delle pietre
come lui: ragazzi già vecchi. Cammina sempre dalla parte giusta delle pietre mani, ogni tanto lo sento sussurrare al vento una preghiera. Om mani padme
mani, ogni tanto lo sento sussurrare al vento una preghiera. Om mani padme hum. Dawa vuole che passiamo dove passa lui, anche se questo costringe a
hum. Dawa vuole che passiamo dove passa lui, anche se questo costringe a scegliere il percorso più tortuoso. Arriviamo a Jorsale dove il Governo ha
scegliere il percorso più tortuoso. Arriviamo a Jorsale dove il Governo ha edificato l'entrata del parco, mentre controllano i nostri documenti leggo sul
edificato l'entrata del parco, mentre controllano i nostri documenti leggo sul tabellone che più di millecinquecento trekkers sono passati di qui tra gennaio
tabellone che più di millecinquecento trekkers sono passati di qui tra gennaio e febbraio. Riprendendo la marcia, attraversiamo magici ponti tibetani
e febbraio. Riprendendo la marcia, attraversiamo magici ponti tibetani ondeggianti nell'aria e ornati da migliaia di cavalli del vento. Davanti a noi si
ondeggianti nell'aria e ornati da migliaia di cavalli del vento. Davanti a noi si staglia nel cielo il Tamserku, un'imponente montagna che supera il seimila
staglia nel cielo il Tamserku, un'imponente montagna che supera il seimila metri. La salita è ancora lunga e abbastanza dura per tutti, anche per un
metri. La salita è ancora lunga e abbastanza dura per tutti, anche per un gruppo di koreani, fermi ad aspettare un loro compagno che beatamente
gruppo di koreani, fermi ad aspettare un loro compagno che beatamente vomita per la quota. Non siamo neanche a 3.500 dico io e già fa questo
vomita per la quota. Non siamo neanche a 3.500 dico io e già fa questo effetto? Mi volto all'improvviso e siamo già a Namche, capitale del popolo
effetto? Mi volto all'improvviso e siamo già a Namche, capitale del popolo Sherpa.
Un tranquillo giorno di mercato
Sherpa.
Un tranquillo giorno di mercato  sabato 12 marzo 2011 Namche (3.440m) giornata di acclimatamento
sabato 12 marzo 2011 Namche (3.440m) giornata di acclimatamento Forse abbiamo esagerato ieri, siamo saliti più del dovuto. Chiara è chiusa nel
Forse abbiamo esagerato ieri, siamo saliti più del dovuto. Chiara è chiusa nel sacco a pelo e borbotta qualcosa che non entra nella mia testa. La camera è
sacco a pelo e borbotta qualcosa che non entra nella mia testa. La camera è gelata, forse dice che sta male, le chiedo cosa sente e mi risponde che
gelata, forse dice che sta male, le chiedo cosa sente e mi risponde che dentro la pancia ha un frullatore. Si alza e vomita. Merda! Almeno oggi è
dentro la pancia ha un frullatore. Si alza e vomita. Merda! Almeno oggi è l'unico giorno di acclimatamento di tutto il viaggio, per cui staremo a vedere.
l'unico giorno di acclimatamento di tutto il viaggio, per cui staremo a vedere. L'accordo è che se uno dei due sta male ci si ferma, e se non ci sono
L'accordo è che se uno dei due sta male ci si ferma, e se non ci sono miglioramenti si scende. Inghiottiamo entrambi una pillola di diamox e
miglioramenti si scende. Inghiottiamo entrambi una pillola di diamox e decidiamo di prenderlo fino al campo base (se mai ci arriveremo). Chiara si
decidiamo di prenderlo fino al campo base (se mai ci arriveremo). Chiara si rimette a letto, poi si alza e vomita anche il diamox, merda! "Stai a letto,
rimette a letto, poi si alza e vomita anche il diamox, merda! "Stai a letto, copriti, torno tra un po'." Mi ritrovo fuori dal lodge nel mezzo di una
copriti, torno tra un po'." Mi ritrovo fuori dal lodge nel mezzo di una confusione inaspettata. È giorno di mercato. Ora ricordo, avevo letto da
confusione inaspettata. È giorno di mercato. Ora ricordo, avevo letto da qualche parte che sabato a Namche è l'apocalisse. Vestiti colorati, verdura,
qualche parte che sabato a Namche è l'apocalisse. Vestiti colorati, verdura, galline, cianfrusaglie, yak, il mercato è un collettore di tante cose che
galline, cianfrusaglie, yak, il mercato è un collettore di tante cose che difficilmente acquisterei. Mi fermo davanti ad una baracca insieme ad un
difficilmente acquisterei. Mi fermo davanti ad una baracca insieme ad un cane che scodinzola. Entro, è la macelleria. La carne è ammassata sul
cane che scodinzola. Entro, è la macelleria. La carne è ammassata sul bancone, c'è poca igiene nell'ambiente, mi chiedo cosa penserebbe questa
bancone, c'è poca igiene nell'ambiente, mi chiedo cosa penserebbe questa gente del nostro mondo asettico. Decido allora di salire oltre il paese, c'è un
gente del nostro mondo asettico. Decido allora di salire oltre il paese, c'è un sentiero ripido che porta ad una pista di atterraggio in terra battuta vicina
sentiero ripido che porta ad una pista di atterraggio in terra battuta vicina all'Hotel Everest View. La pista ora è poco utilizzata visto che molti soffrono
all'Hotel Everest View. La pista ora è poco utilizzata visto che molti soffrono la quota arrivando qui direttamente da Kathmandu. Dall'alto Namche è
la quota arrivando qui direttamente da Kathmandu. Dall'alto Namche è estremamente suggestiva, un anfiteatro di case con il tetto azzurro
estremamente suggestiva, un anfiteatro di case con il tetto azzurro contornate da colossi innevati, tra cui fa già capolino l'Everest e la sua
contornate da colossi innevati, tra cui fa già capolino l'Everest e la sua inconfondibile piramide sommitale nera. Torno in hotel eccitato da quella
inconfondibile piramide sommitale nera. Torno in hotel eccitato da quella visione e noto che Chiara sta un po' meglio. Decidiamo di fare un giro al
visione e noto che Chiara sta un po' meglio. Decidiamo di fare un giro al museo del Parco Nazionale del Sagharmata. Poi shopping e vedo che questa
museo del Parco Nazionale del Sagharmata. Poi shopping e vedo che questa è la miglior medicina per Chiara che ora ha recuperato. Dentro di me sono
è la miglior medicina per Chiara che ora ha recuperato. Dentro di me sono felice come uno yak davanti a un prato verde.
felice come uno yak davanti a un prato verde. La ballata del vecchio marinario
La ballata del vecchio marinario  domenica 13 marzo 2011 Namche (3.440) - Pangboche (3.930)
I rigori di marzo riescono a penetrare anche la nostra stanza, al mattino
domenica 13 marzo 2011 Namche (3.440) - Pangboche (3.930)
I rigori di marzo riescono a penetrare anche la nostra stanza, al mattino troviamo le bottiglie d'acqua ghiacciate. Non vediamo l'ora di uscire dal
troviamo le bottiglie d'acqua ghiacciate. Non vediamo l'ora di uscire dal lodge, per respirare l'aria scaldata dal sole. Oggi ci aspetta un lungo tratto.
lodge, per respirare l'aria scaldata dal sole. Oggi ci aspetta un lungo tratto. All'orizzonte, oltre il sentiero, spunta l'Ama Dablan, una creatura di roccia e
All'orizzonte, oltre il sentiero, spunta l'Ama Dablan, una creatura di roccia e ghiaccio che pare scolpita e avvitata là. Incontriamo subito alcuni operai
ghiaccio che pare scolpita e avvitata là. Incontriamo subito alcuni operai nepalesi intenti a sistemare il sentiero, con loro c'è un vecchio, seduto ad un
nepalesi intenti a sistemare il sentiero, con loro c'è un vecchio, seduto ad un banchetto. Occhiali da sole e giacca a vento, ha il volto stanco, provato dagli
banchetto. Occhiali da sole e giacca a vento, ha il volto stanco, provato dagli anni, chiede un'offerta per l'opera di manutenzione. Anche noi apriamo il
anni, chiede un'offerta per l'opera di manutenzione. Anche noi apriamo il portafoglio senza pensarci e firmiamo un libro. Mi accorgo che Rajan lo tratta
portafoglio senza pensarci e firmiamo un libro. Mi accorgo che Rajan lo tratta con un'attenzione insolita, gli parla piano, non lo fissa negli occhi. Poco più
con un'attenzione insolita, gli parla piano, non lo fissa negli occhi. Poco più avanti camminando il nostro portatore mi racconta come conobbe quell'uomo
avanti camminando il nostro portatore mi racconta come conobbe quell'uomo durante un trekking alcuni anni prima. Mi torna alla mente la ballata del
durante un trekking alcuni anni prima. Mi torna alla mente la ballata del vecchio marinaio di Coleridge, dove un vecchio ferma un giovane per
vecchio marinaio di Coleridge, dove un vecchio ferma un giovane per raccontargli una storia terribile. Fece così anche quell'uomo: forse per espiare
raccontargli una storia terribile. Fece così anche quell'uomo: forse per espiare la sua colpa o perché da sempre è più facile confessare che perdonarsi. Un
la sua colpa o perché da sempre è più facile confessare che perdonarsi. Un giorno egli si recò ad un matrimonio. Là si ubriacò senza ritegno. Tornando a
giorno egli si recò ad un matrimonio. Là si ubriacò senza ritegno. Tornando a casa, preso da chissà quale delirio uccise la moglie e il figlio ancora piccolo.
casa, preso da chissà quale delirio uccise la moglie e il figlio ancora piccolo. Trascorse buona parte della sua vita in galera. Divenuto ormai un vecchio
Trascorse buona parte della sua vita in galera. Divenuto ormai un vecchio inoffensivo fu scarcerato e impiegato nei lavori di riparazione dei sentieri. E
inoffensivo fu scarcerato e impiegato nei lavori di riparazione dei sentieri. E proprio lungo questo sentiero oggi incontriamo numerosi yak, sono bestie
proprio lungo questo sentiero oggi incontriamo numerosi yak, sono bestie enormi e poco affabili. Cerco di ricordarmi la parola maestra di Rajan, e cioè
enormi e poco affabili. Cerco di ricordarmi la parola maestra di Rajan, e cioè che l'importante è incrociare uno yak fermandosi dalla parte dove non c'è il
che l'importante è incrociare uno yak fermandosi dalla parte dove non c'è il dirupo. Scendiamo risaliamo verso un passo, in breve siamo a Tengboche.
dirupo. Scendiamo risaliamo verso un passo, in breve siamo a Tengboche. Qui c'è il monastero più grande della valle del Kumbu, entrando un monaco ci
Qui c'è il monastero più grande della valle del Kumbu, entrando un monaco ci sorride mentre i miei occhi fissano curiosi la grande statua dorata del
sorride mentre i miei occhi fissano curiosi la grande statua dorata del Buddha. Usciamo nel piccolo cortile del monastero, immaginiamo come deve
Buddha. Usciamo nel piccolo cortile del monastero, immaginiamo come deve aNeemarsi quel piccolo luogo in occasione della festa del Mani Rimdu. Siamo
aNeemarsi quel piccolo luogo in occasione della festa del Mani Rimdu. Siamo stanchi ma la visita a Tengboche ci ha regalato una emozione viva che ci
stanchi ma la visita a Tengboche ci ha regalato una emozione viva che ci accompagna fino a Pangboche, dove ci attende una camera e un buona
accompagna fino a Pangboche, dove ci attende una camera e un buona zuppa all'aglio. (...continua con la 2a parte)
zuppa all'aglio. (...continua con la 2a parte)
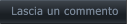 Racconti
Racconti















 La pista in salita dell’aeroporto di Lukla
Welcome to Lukla airport
La pista in salita dell’aeroporto di Lukla
Welcome to Lukla airport






 Un portatore con un carico pesante
Il nostro portatore Dawa e Chiara
Ponte sospeso con i cavalli del vento
Namche Bazar
Chiara K.O.
Matteo a Namche
Un portatore con un carico pesante
Il nostro portatore Dawa e Chiara
Ponte sospeso con i cavalli del vento
Namche Bazar
Chiara K.O.
Matteo a Namche

 Tara Air super confort
Tara Air super confort
 Le prime montagne imbiancate: Tamserku
Chiara O.K.
Le prime montagne imbiancate: Tamserku
Chiara O.K.
 L’inconfondibile forma dell’ama Dablan
L’inconfondibile forma dell’ama Dablan
 Il vecchio e il suo terribile passato
Il vecchio e il suo terribile passato
 L’incredibile monastero di Tengboche
L’incredibile monastero di Tengboche
 Sterco di yak ad essiccare al sole
usato come combustibile super ecologico
Sterco di yak ad essiccare al sole
usato come combustibile super ecologico



 Vita nei villaggi
Vita nei villaggi

 Appena sopra Namche si vede la cima
dell’Everest sulla sinistra
Il sentiero che porta a Namche è costellato
di piete mani, chorten e cavalli del vento
Appena sopra Namche si vede la cima
dell’Everest sulla sinistra
Il sentiero che porta a Namche è costellato
di piete mani, chorten e cavalli del vento
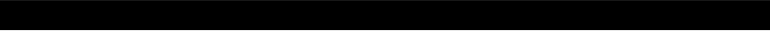

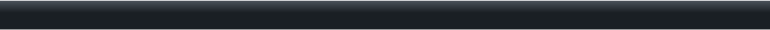


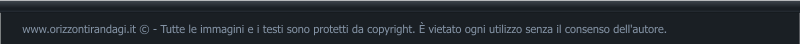
 Fuga da Lukla - Viaggio al Campo Base dell’Everest (parte1)
di Matteo Bergamo
"E sulla bianca schiena dell'animale egli scaricò la somma della rabbia e l'odio provati
Fuga da Lukla - Viaggio al Campo Base dell’Everest (parte1)
di Matteo Bergamo
"E sulla bianca schiena dell'animale egli scaricò la somma della rabbia e l'odio provati dalla propria razza; se il suo petto fosse stato un cannone, egli, gli avrebbe sparato
dalla propria razza; se il suo petto fosse stato un cannone, egli, gli avrebbe sparato contro il suo cuore."
contro il suo cuore." Moby Dick, Herman Melville
Moby Dick, Herman Melville Ci sono alcune montagne che suonano alle mie orecchie come la grande
Ci sono alcune montagne che suonano alle mie orecchie come la grande ossessione del Capitano Achab. Stagione dopo stagione ci reclamano come
ossessione del Capitano Achab. Stagione dopo stagione ci reclamano come sirene maliarde, rocce tramutate in libri di storia e cimiteri viventi
sirene maliarde, rocce tramutate in libri di storia e cimiteri viventi dell'alpinismo. Questa è la loro fascinazione: un costante richiamo alla sfida,
dell'alpinismo. Questa è la loro fascinazione: un costante richiamo alla sfida, ad affrontare i molti mostri che abitano dentro di noi e gli altrettanti pericoli
ad affrontare i molti mostri che abitano dentro di noi e gli altrettanti pericoli fuori. Al trekking del campo base dell'Everest, bisognerebbe amputare la
fuori. Al trekking del campo base dell'Everest, bisognerebbe amputare la parola trekking perché è prima di tutto un viaggio. Un viaggio che inizia con il
parola trekking perché è prima di tutto un viaggio. Un viaggio che inizia con il ronzio dell'elica di un aereo. È già un buon risultato sbarcare a Lukla, in
ronzio dell'elica di un aereo. È già un buon risultato sbarcare a Lukla, in assoluto uno degli aeroporti più insidiosi, incassato tra le montagne come un
assoluto uno degli aeroporti più insidiosi, incassato tra le montagne come un chicco di mais dentro una pannocchia.
chicco di mais dentro una pannocchia.  Katmandu-Lukla sola andata
Katmandu-Lukla sola andata venerdì 11 marzo 2011 ore 5.00 aeroporto di Katmandu
venerdì 11 marzo 2011 ore 5.00 aeroporto di Katmandu L'aeroporto domestico di Kathmandu è un mare agitato: grandi cartoni tenuti
L'aeroporto domestico di Kathmandu è un mare agitato: grandi cartoni tenuti insieme da fili del bucato, ondate di disordine e turisti alla deriva. Fuori è
insieme da fili del bucato, ondate di disordine e turisti alla deriva. Fuori è ancora buio, le luci dei neon complicano ancor di più la mia comprensione di
ancora buio, le luci dei neon complicano ancor di più la mia comprensione di quel mondo brulicante. Tè a colazione, poi saliamo finalmente sull'aereo: è
quel mondo brulicante. Tè a colazione, poi saliamo finalmente sull'aereo: è un insetto pigro, dal muso lungo e una porticina sulla parte posteriore della
un insetto pigro, dal muso lungo e una porticina sulla parte posteriore della carlinga. Ci accoglie una hostess e una quindicina di posti appiccicati tra loro,
carlinga. Ci accoglie una hostess e una quindicina di posti appiccicati tra loro, quasi tutti occupati. La libellula ronza un po', poi si alza in volo. La faccina di
quasi tutti occupati. La libellula ronza un po', poi si alza in volo. La faccina di Chiara è tesa non ha molta fiducia negli aerei che portano il nome Yeti,
Chiara è tesa non ha molta fiducia negli aerei che portano il nome Yeti, Buddha, Tara. Anch'io sono inquieto, sussulto al grido degli altri trekkers che,
Buddha, Tara. Anch'io sono inquieto, sussulto al grido degli altri trekkers che, alla vista delle prime montagne imbiancate, schiacciano le macchine
alla vista delle prime montagne imbiancate, schiacciano le macchine fotografiche contro i finestrini. Dalla mia parte vedo solo terra brulla, che
fotografiche contro i finestrini. Dalla mia parte vedo solo terra brulla, che scemo che sono! Dovevo sedermi dall'altro lato. Dopo cinquanta minuti di
scemo che sono! Dovevo sedermi dall'altro lato. Dopo cinquanta minuti di volo, attraverso i finestrini dei piloti le montagne sembrano farsi sempre più
volo, attraverso i finestrini dei piloti le montagne sembrano farsi sempre più vicine. Improvvisamente tutti tacciono, quindici impulsi cardiaci si fanno ora
vicine. Improvvisamente tutti tacciono, quindici impulsi cardiaci si fanno ora più veloci in quello spazio angusto, l'atterraggio è la discriminante di un
più veloci in quello spazio angusto, l'atterraggio è la discriminante di un viaggio da ricordare oppure no. Quando tocchiamo terra l'aereo singhiozza
viaggio da ricordare oppure no. Quando tocchiamo terra l'aereo singhiozza poi frena bruscamente nel tentativo di arrestare la sua corsa nei
poi frena bruscamente nel tentativo di arrestare la sua corsa nei quattrocentocinquanta metri scarsi di pista in salita. Le chiappe sono strette,
quattrocentocinquanta metri scarsi di pista in salita. Le chiappe sono strette, ogni pensiero revocato. La libellula finisce la sua corsa con un scarto verso
ogni pensiero revocato. La libellula finisce la sua corsa con un scarto verso destra. Ci sarebbe da baciare il suolo, ma simulo una perfetta padronanza dei
destra. Ci sarebbe da baciare il suolo, ma simulo una perfetta padronanza dei miei sentimenti mentre scendo a terra. Veniamo dirottati nel casotto dei
miei sentimenti mentre scendo a terra. Veniamo dirottati nel casotto dei bagagli. Attraverso la rete che delimita l'aeroporto vedo numerosi portatori in
bagagli. Attraverso la rete che delimita l'aeroporto vedo numerosi portatori in attesa. Che aspettano? Noi? Sì, aspettano le vacche d'oro, pronte per essere
attesa. Che aspettano? Noi? Sì, aspettano le vacche d'oro, pronte per essere accompagnate e munte. Nelle loro facce buie è scritta color della terra la
accompagnate e munte. Nelle loro facce buie è scritta color della terra la povertà, l'espediente, la rassegnazione, che insieme condensano in un
povertà, l'espediente, la rassegnazione, che insieme condensano in un inglese mal masticato e rivolto a noi: "Porter, Sir?", "Everest Base Camp, Sir?"
inglese mal masticato e rivolto a noi: "Porter, Sir?", "Everest Base Camp, Sir?"  Om mani padme hum
Om mani padme hum venerdì 11 marzo 2011 Lukla (2.800 m) - Namche (3.440m)
venerdì 11 marzo 2011 Lukla (2.800 m) - Namche (3.440m)  Namche è la nostra prima destinazione, di solito si affronta in due tappe
Namche è la nostra prima destinazione, di solito si affronta in due tappe dormendo a Padking, ma la spedizione italo-parmigiana (io e mia moglie) ha
dormendo a Padking, ma la spedizione italo-parmigiana (io e mia moglie) ha la coperta corta. Quando penso ai nostri viaggi mi chiedo se è sano
la coperta corta. Quando penso ai nostri viaggi mi chiedo se è sano rincorrere in questo modo il tempo. Dobbiamo chiudere il giro in appena
rincorrere in questo modo il tempo. Dobbiamo chiudere il giro in appena sette, otto giorni, ma sappiamo bene che ad alta quota la fretta è amica solo
sette, otto giorni, ma sappiamo bene che ad alta quota la fretta è amica solo dei guai. Il mal di montagna è un preoccupante punto interrogativo nelle
dei guai. Il mal di montagna è un preoccupante punto interrogativo nelle nostre coscienze. Procediamo attraverso un portale decorato che preannuncia
nostre coscienze. Procediamo attraverso un portale decorato che preannuncia l'inizio di una memorabile sgambettata. Seguiamo un sentiero dolce, in lieve
l'inizio di una memorabile sgambettata. Seguiamo un sentiero dolce, in lieve discesa, attraversando decorosi, piccoli villaggi. La vegetazione è rigogliosa,
discesa, attraversando decorosi, piccoli villaggi. La vegetazione è rigogliosa, grandi boschi di rododendro e conifere si alternano a coltivazioni e terre da
grandi boschi di rododendro e conifere si alternano a coltivazioni e terre da pascolo. Viaggiamo attraverso le numerose tracce della religiosità di questo
pascolo. Viaggiamo attraverso le numerose tracce della religiosità di questo popolo: le ruote di preghiera, i cavalli del vento, le pietre mani. Guardo i
popolo: le ruote di preghiera, i cavalli del vento, le pietre mani. Guardo i nostri due portatori, chi sono? È un fattore istintivo per me conoscere chi mi
nostri due portatori, chi sono? È un fattore istintivo per me conoscere chi mi cammina a fianco giorno dopo giorno. È una questione di appartenenza alla
cammina a fianco giorno dopo giorno. È una questione di appartenenza alla stessa specie, quella che fatica e suda insieme, che condivide il sole, la
stessa specie, quella che fatica e suda insieme, che condivide il sole, la pioggia, il vento e la sete. Faccio una fatica tremenda ad accettare che
pioggia, il vento e la sete. Faccio una fatica tremenda ad accettare che trasportino la parte più pesante del mio zaino anche se sono meglio
trasportino la parte più pesante del mio zaino anche se sono meglio acclimatati e sembra che i loro 10/15 kg siano molto più leggeri dei nostri 5.
acclimatati e sembra che i loro 10/15 kg siano molto più leggeri dei nostri 5. Rajan è quello dei due che meglio parla inglese, socievole, robusto, con
Rajan è quello dei due che meglio parla inglese, socievole, robusto, con capelli lunghi e scuri. Ha iniziato come sherpa, poi come cuoco, la famiglia gli
capelli lunghi e scuri. Ha iniziato come sherpa, poi come cuoco, la famiglia gli ha combinato un matrimonio che è finito quando lei, trovandosi ogni santa
ha combinato un matrimonio che è finito quando lei, trovandosi ogni santa notte da sola, si è innamorata di un altro uomo. Ogni volta che ci vede
notte da sola, si è innamorata di un altro uomo. Ogni volta che ci vede sorride, ma il suo sorriso più sincero è quando si tocca la pancia dopo aver
sorride, ma il suo sorriso più sincero è quando si tocca la pancia dopo aver mangiato. L'altro sherpa è Dawa. Smilzo, taciturno, anche lui perennemente
mangiato. L'altro sherpa è Dawa. Smilzo, taciturno, anche lui perennemente affamato. È stato sposato ed ha consumato tutti i suoi soldi per curare
affamato. È stato sposato ed ha consumato tutti i suoi soldi per curare inutilmente la moglie colpita da un male spietato. Ora si è risposato ed ha tre
inutilmente la moglie colpita da un male spietato. Ora si è risposato ed ha tre bocche da sfamare. Quando lo guardo sono io che sorrido: sembra un
bocche da sfamare. Quando lo guardo sono io che sorrido: sembra un bambino imprigionato nell'aspetto di un uomo saggio. Tanti sherpa sono
bambino imprigionato nell'aspetto di un uomo saggio. Tanti sherpa sono come lui: ragazzi già vecchi. Cammina sempre dalla parte giusta delle pietre
come lui: ragazzi già vecchi. Cammina sempre dalla parte giusta delle pietre mani, ogni tanto lo sento sussurrare al vento una preghiera. Om mani padme
mani, ogni tanto lo sento sussurrare al vento una preghiera. Om mani padme hum. Dawa vuole che passiamo dove passa lui, anche se questo costringe a
hum. Dawa vuole che passiamo dove passa lui, anche se questo costringe a scegliere il percorso più tortuoso. Arriviamo a Jorsale dove il Governo ha
scegliere il percorso più tortuoso. Arriviamo a Jorsale dove il Governo ha edificato l'entrata del parco, mentre controllano i nostri documenti leggo sul
edificato l'entrata del parco, mentre controllano i nostri documenti leggo sul tabellone che più di millecinquecento trekkers sono passati di qui tra gennaio
tabellone che più di millecinquecento trekkers sono passati di qui tra gennaio e febbraio. Riprendendo la marcia, attraversiamo magici ponti tibetani
e febbraio. Riprendendo la marcia, attraversiamo magici ponti tibetani ondeggianti nell'aria e ornati da migliaia di cavalli del vento. Davanti a noi si
ondeggianti nell'aria e ornati da migliaia di cavalli del vento. Davanti a noi si staglia nel cielo il Tamserku, un'imponente montagna che supera il seimila
staglia nel cielo il Tamserku, un'imponente montagna che supera il seimila metri. La salita è ancora lunga e abbastanza dura per tutti, anche per un
metri. La salita è ancora lunga e abbastanza dura per tutti, anche per un gruppo di koreani, fermi ad aspettare un loro compagno che beatamente
gruppo di koreani, fermi ad aspettare un loro compagno che beatamente vomita per la quota. Non siamo neanche a 3.500 dico io e già fa questo
vomita per la quota. Non siamo neanche a 3.500 dico io e già fa questo effetto? Mi volto all'improvviso e siamo già a Namche, capitale del popolo
effetto? Mi volto all'improvviso e siamo già a Namche, capitale del popolo Sherpa.
Un tranquillo giorno di mercato
Sherpa.
Un tranquillo giorno di mercato  sabato 12 marzo 2011 Namche (3.440m) giornata di acclimatamento
sabato 12 marzo 2011 Namche (3.440m) giornata di acclimatamento Forse abbiamo esagerato ieri, siamo saliti più del dovuto. Chiara è chiusa nel
Forse abbiamo esagerato ieri, siamo saliti più del dovuto. Chiara è chiusa nel sacco a pelo e borbotta qualcosa che non entra nella mia testa. La camera è
sacco a pelo e borbotta qualcosa che non entra nella mia testa. La camera è gelata, forse dice che sta male, le chiedo cosa sente e mi risponde che
gelata, forse dice che sta male, le chiedo cosa sente e mi risponde che dentro la pancia ha un frullatore. Si alza e vomita. Merda! Almeno oggi è
dentro la pancia ha un frullatore. Si alza e vomita. Merda! Almeno oggi è l'unico giorno di acclimatamento di tutto il viaggio, per cui staremo a vedere.
l'unico giorno di acclimatamento di tutto il viaggio, per cui staremo a vedere. L'accordo è che se uno dei due sta male ci si ferma, e se non ci sono
L'accordo è che se uno dei due sta male ci si ferma, e se non ci sono miglioramenti si scende. Inghiottiamo entrambi una pillola di diamox e
miglioramenti si scende. Inghiottiamo entrambi una pillola di diamox e decidiamo di prenderlo fino al campo base (se mai ci arriveremo). Chiara si
decidiamo di prenderlo fino al campo base (se mai ci arriveremo). Chiara si rimette a letto, poi si alza e vomita anche il diamox, merda! "Stai a letto,
rimette a letto, poi si alza e vomita anche il diamox, merda! "Stai a letto, copriti, torno tra un po'." Mi ritrovo fuori dal lodge nel mezzo di una
copriti, torno tra un po'." Mi ritrovo fuori dal lodge nel mezzo di una confusione inaspettata. È giorno di mercato. Ora ricordo, avevo letto da
confusione inaspettata. È giorno di mercato. Ora ricordo, avevo letto da qualche parte che sabato a Namche è l'apocalisse. Vestiti colorati, verdura,
qualche parte che sabato a Namche è l'apocalisse. Vestiti colorati, verdura, galline, cianfrusaglie, yak, il mercato è un collettore di tante cose che
galline, cianfrusaglie, yak, il mercato è un collettore di tante cose che difficilmente acquisterei. Mi fermo davanti ad una baracca insieme ad un
difficilmente acquisterei. Mi fermo davanti ad una baracca insieme ad un cane che scodinzola. Entro, è la macelleria. La carne è ammassata sul
cane che scodinzola. Entro, è la macelleria. La carne è ammassata sul bancone, c'è poca igiene nell'ambiente, mi chiedo cosa penserebbe questa
bancone, c'è poca igiene nell'ambiente, mi chiedo cosa penserebbe questa gente del nostro mondo asettico. Decido allora di salire oltre il paese, c'è un
gente del nostro mondo asettico. Decido allora di salire oltre il paese, c'è un sentiero ripido che porta ad una pista di atterraggio in terra battuta vicina
sentiero ripido che porta ad una pista di atterraggio in terra battuta vicina all'Hotel Everest View. La pista ora è poco utilizzata visto che molti soffrono
all'Hotel Everest View. La pista ora è poco utilizzata visto che molti soffrono la quota arrivando qui direttamente da Kathmandu. Dall'alto Namche è
la quota arrivando qui direttamente da Kathmandu. Dall'alto Namche è estremamente suggestiva, un anfiteatro di case con il tetto azzurro
estremamente suggestiva, un anfiteatro di case con il tetto azzurro contornate da colossi innevati, tra cui fa già capolino l'Everest e la sua
contornate da colossi innevati, tra cui fa già capolino l'Everest e la sua inconfondibile piramide sommitale nera. Torno in hotel eccitato da quella
inconfondibile piramide sommitale nera. Torno in hotel eccitato da quella visione e noto che Chiara sta un po' meglio. Decidiamo di fare un giro al
visione e noto che Chiara sta un po' meglio. Decidiamo di fare un giro al museo del Parco Nazionale del Sagharmata. Poi shopping e vedo che questa
museo del Parco Nazionale del Sagharmata. Poi shopping e vedo che questa è la miglior medicina per Chiara che ora ha recuperato. Dentro di me sono
è la miglior medicina per Chiara che ora ha recuperato. Dentro di me sono felice come uno yak davanti a un prato verde.
felice come uno yak davanti a un prato verde. La ballata del vecchio marinario
La ballata del vecchio marinario  domenica 13 marzo 2011 Namche (3.440) - Pangboche (3.930)
I rigori di marzo riescono a penetrare anche la nostra stanza, al mattino
domenica 13 marzo 2011 Namche (3.440) - Pangboche (3.930)
I rigori di marzo riescono a penetrare anche la nostra stanza, al mattino troviamo le bottiglie d'acqua ghiacciate. Non vediamo l'ora di uscire dal
troviamo le bottiglie d'acqua ghiacciate. Non vediamo l'ora di uscire dal lodge, per respirare l'aria scaldata dal sole. Oggi ci aspetta un lungo tratto.
lodge, per respirare l'aria scaldata dal sole. Oggi ci aspetta un lungo tratto. All'orizzonte, oltre il sentiero, spunta l'Ama Dablan, una creatura di roccia e
All'orizzonte, oltre il sentiero, spunta l'Ama Dablan, una creatura di roccia e ghiaccio che pare scolpita e avvitata là. Incontriamo subito alcuni operai
ghiaccio che pare scolpita e avvitata là. Incontriamo subito alcuni operai nepalesi intenti a sistemare il sentiero, con loro c'è un vecchio, seduto ad un
nepalesi intenti a sistemare il sentiero, con loro c'è un vecchio, seduto ad un banchetto. Occhiali da sole e giacca a vento, ha il volto stanco, provato dagli
banchetto. Occhiali da sole e giacca a vento, ha il volto stanco, provato dagli anni, chiede un'offerta per l'opera di manutenzione. Anche noi apriamo il
anni, chiede un'offerta per l'opera di manutenzione. Anche noi apriamo il portafoglio senza pensarci e firmiamo un libro. Mi accorgo che Rajan lo tratta
portafoglio senza pensarci e firmiamo un libro. Mi accorgo che Rajan lo tratta con un'attenzione insolita, gli parla piano, non lo fissa negli occhi. Poco più
con un'attenzione insolita, gli parla piano, non lo fissa negli occhi. Poco più avanti camminando il nostro portatore mi racconta come conobbe quell'uomo
avanti camminando il nostro portatore mi racconta come conobbe quell'uomo durante un trekking alcuni anni prima. Mi torna alla mente la ballata del
durante un trekking alcuni anni prima. Mi torna alla mente la ballata del vecchio marinaio di Coleridge, dove un vecchio ferma un giovane per
vecchio marinaio di Coleridge, dove un vecchio ferma un giovane per raccontargli una storia terribile. Fece così anche quell'uomo: forse per espiare
raccontargli una storia terribile. Fece così anche quell'uomo: forse per espiare la sua colpa o perché da sempre è più facile confessare che perdonarsi. Un
la sua colpa o perché da sempre è più facile confessare che perdonarsi. Un giorno egli si recò ad un matrimonio. Là si ubriacò senza ritegno. Tornando a
giorno egli si recò ad un matrimonio. Là si ubriacò senza ritegno. Tornando a casa, preso da chissà quale delirio uccise la moglie e il figlio ancora piccolo.
casa, preso da chissà quale delirio uccise la moglie e il figlio ancora piccolo. Trascorse buona parte della sua vita in galera. Divenuto ormai un vecchio
Trascorse buona parte della sua vita in galera. Divenuto ormai un vecchio inoffensivo fu scarcerato e impiegato nei lavori di riparazione dei sentieri. E
inoffensivo fu scarcerato e impiegato nei lavori di riparazione dei sentieri. E proprio lungo questo sentiero oggi incontriamo numerosi yak, sono bestie
proprio lungo questo sentiero oggi incontriamo numerosi yak, sono bestie enormi e poco affabili. Cerco di ricordarmi la parola maestra di Rajan, e cioè
enormi e poco affabili. Cerco di ricordarmi la parola maestra di Rajan, e cioè che l'importante è incrociare uno yak fermandosi dalla parte dove non c'è il
che l'importante è incrociare uno yak fermandosi dalla parte dove non c'è il dirupo. Scendiamo risaliamo verso un passo, in breve siamo a Tengboche.
dirupo. Scendiamo risaliamo verso un passo, in breve siamo a Tengboche. Qui c'è il monastero più grande della valle del Kumbu, entrando un monaco ci
Qui c'è il monastero più grande della valle del Kumbu, entrando un monaco ci sorride mentre i miei occhi fissano curiosi la grande statua dorata del
sorride mentre i miei occhi fissano curiosi la grande statua dorata del Buddha. Usciamo nel piccolo cortile del monastero, immaginiamo come deve
Buddha. Usciamo nel piccolo cortile del monastero, immaginiamo come deve aNeemarsi quel piccolo luogo in occasione della festa del Mani Rimdu. Siamo
aNeemarsi quel piccolo luogo in occasione della festa del Mani Rimdu. Siamo stanchi ma la visita a Tengboche ci ha regalato una emozione viva che ci
stanchi ma la visita a Tengboche ci ha regalato una emozione viva che ci accompagna fino a Pangboche, dove ci attende una camera e un buona
accompagna fino a Pangboche, dove ci attende una camera e un buona zuppa all'aglio. (...continua con la 2a parte)
zuppa all'aglio. (...continua con la 2a parte)
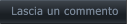 Racconti
Racconti















 La pista in salita dell’aeroporto di Lukla
Welcome to Lukla airport
La pista in salita dell’aeroporto di Lukla
Welcome to Lukla airport






 Un portatore con un carico pesante
Il nostro portatore Dawa e Chiara
Ponte sospeso con i cavalli del vento
Namche Bazar
Chiara K.O.
Matteo a Namche
Un portatore con un carico pesante
Il nostro portatore Dawa e Chiara
Ponte sospeso con i cavalli del vento
Namche Bazar
Chiara K.O.
Matteo a Namche

 Tara Air super confort
Tara Air super confort
 Le prime montagne imbiancate: Tamserku
Chiara O.K.
Le prime montagne imbiancate: Tamserku
Chiara O.K.
 L’inconfondibile forma dell’ama Dablan
L’inconfondibile forma dell’ama Dablan
 Il vecchio e il suo terribile passato
Il vecchio e il suo terribile passato
 L’incredibile monastero di Tengboche
L’incredibile monastero di Tengboche
 Sterco di yak ad essiccare al sole
usato come combustibile super ecologico
Sterco di yak ad essiccare al sole
usato come combustibile super ecologico



 Vita nei villaggi
Vita nei villaggi

 Appena sopra Namche si vede la cima
dell’Everest sulla sinistra
Il sentiero che porta a Namche è costellato
di piete mani, chorten e cavalli del vento
Appena sopra Namche si vede la cima
dell’Everest sulla sinistra
Il sentiero che porta a Namche è costellato
di piete mani, chorten e cavalli del vento










